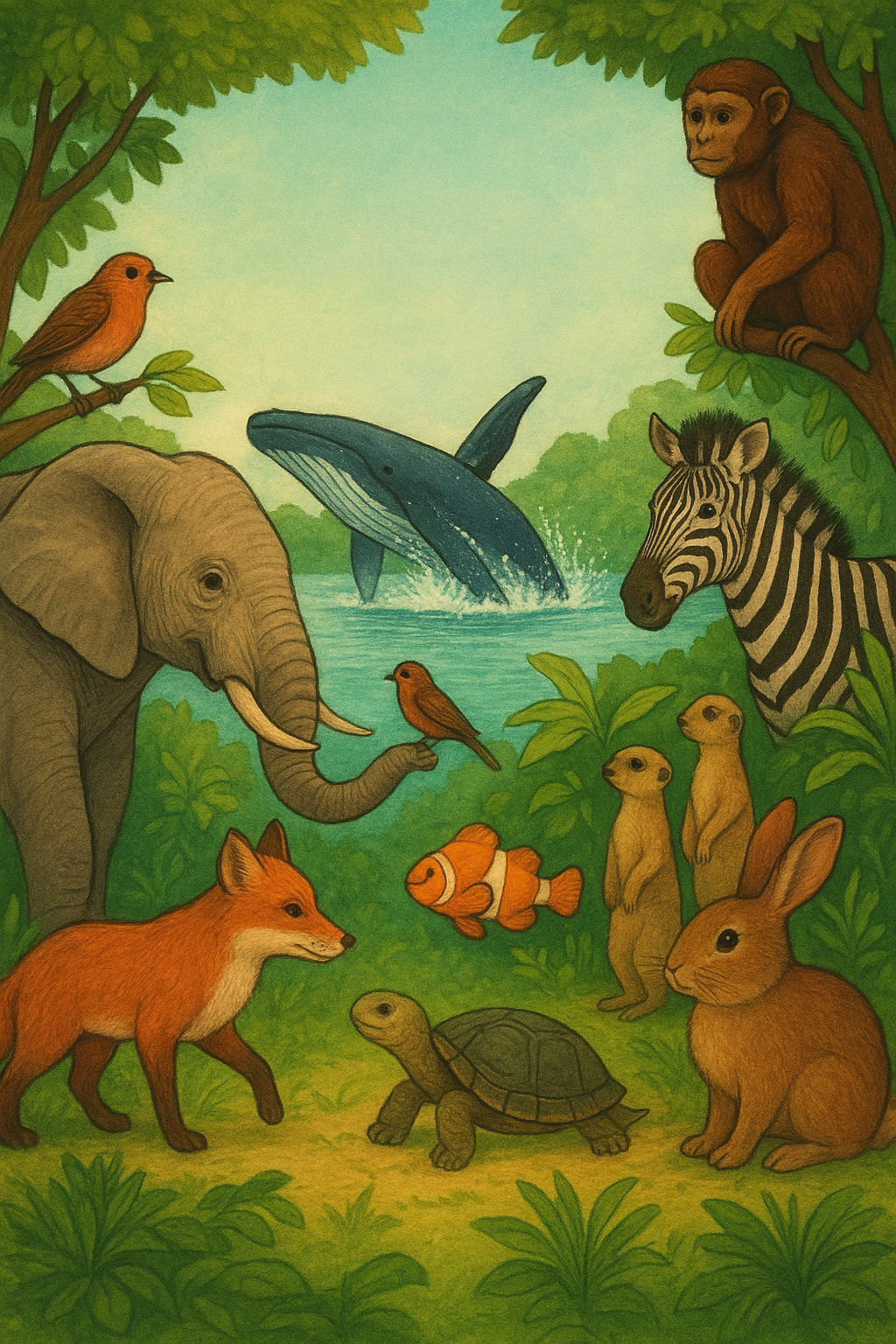Di Angelo Tartabini
In molte culture animali e umane l’ostentazione degli organi sessuali può assumere dei significati diversi da quelli per i quali vengono principalmente utilizzati, cioè per accoppiarsi, indipendentemente dal fatto che lo scopo sia o non sia riproduttivo. Gli organi sessuali, principalmente quelli maschili, possono anche essere usati a scopo dimostrativo, impositivo e persino scaramantico. Nelle dispute tra ragazzini l’abbiamo fatto tutti, purtroppo qualcuno lo fa anche da adulto, cioè toccarsi i genitali di fronte a un pericolo appena scampato, per quanto questo gesto possa essere volgare. Non dobbiamo meravigliarci, alcuni ministri del nostro Paese hanno fatto di peggio! Quindi, non vuol dire che chi mette in atto un gesto come questo, manifesti apertamente il desiderio di accoppiarsi, quanto piuttosto quello di mettere in chiaro la sua posizione di dominanza e anche, per assurdo, di dimostrarsi disponibile ad aiutare e proteggere i più deboli, ammesso che questi non desiderino prendere il suo posto o scalzarlo. Queste dimostrazioni sono chiare nella cosiddetta monta ritualizzata, comportamento molto comune nelle scimmie, ma anche negli adolescenti, che lo possono fare anche per gioco, e che non ha niente a che fare con l’omosessualità. Si tratta della dimostrazione dell’esistenza di una gerarchia che deve essere rispettata, altrimenti si potrebbe passare a vie di fatto, un colpo repentino, un attacco collettivo e furibondo con conseguenze che a volte possono essere molto gravi, anche mortali.
Gli indiani d’America, quando erano in guerra con i coloni europei e invasori, usavano dipingersi il viso con dei colori molto forti e mettersi delle piume di uccelli in testa per incutere soggezione al nemico e per dimostrare che loro erano i padroni del territorio. Ora questi segnali non sono stati completamente cancellati, ma si sono invece modificati o, meglio, sono passati in altre parte del corpo, per esempio dal viso ai genitali. Nel Medioevo i genitali dei guerrieri non venivano affatto celati, ma anzi messi in evidenza con delle coppe di cuoio e di acciaio nelle armature. Questi segnali sono rimasti persino nell’uomo di oggi, per esempio nelle cerniere o nei bottoni della patta dei pantaloni, solo che non ne siamo sempre consapevoli, non ci facciamo caso. Non è infatti una combinazione che la moda unisex sia stata fallimentare. È praticamente scomparsa dal mercato. L’identità sessuale doveva essere mantenuta, né equivocata, né ritrasferita altrove, cioè in altre parti del corpo.
L’esibizionismo sessuale, soprattutto quello maschile, è dovuto, e così è sempre stato, al desiderio di imporsi, di padroneggiare e dominare. Non è un caso che nel linguaggio comune, per segnalare chi comanda in una famiglia, si usi spesso un’espressione del tipo: chi porta i pantaloni in questa casa?
Questo esibizionismo è talmente diffuso nel mondo che secondo alcune tradizioni culturali giapponese del passato, anche recente, gli uomini quando siedono tendono ad allargare le gambe (ora questo è molto più sfumato), mentre le donne tendono a restringerle, indipendentemente dal fatto che portino i pantaloni o la gonna. Nell’antica tradizione nipponica gli uomini portavano il chimono che consentiva l’allargamento delle gambe, mentre quello delle donne non lo consentiva. Un samurai, nell’immaginario collettivo giapponese, non è mai stato rappresentato da seduto a gambe congiunte, mai con il posteriore poggiato sui talloni, come invece facevano le donne sedute sul tatami che prima piegavano le ginocchia a gambe congiunte, poi accostavano il chimono agli stinchi ed infine si sedevano ricadendo prima sui polpacci e poi sulle piante dei piedi. Queste ritualità in Giappone si sono, più o meno, mantenute, e le ritroviamo sia nell’intimità familiare, sia in pubblico, soprattutto durante le cerimonie, per esempio quella del tè, o quella dei funerali. Il risultato è che la donna giapponese, nonostante da tempo abbia iniziato a portare i pantaloni, non si è ancora totalmente liberata da questi costumi. Nelle comunità agricole giapponesi dei nostri giorni queste usanze sono ancora diffuse; nelle città le cose sono cambiate, anche perché i giapponesi che si sono occidentalizzati e che non vivono più nelle tipiche case nipponiche di legno, con tatami, futon, altarini shinto e altro di questo genere, non ne consentono più le manifestazioni.
Nell’accoppiamento c’è sempre la tendenza impositoria dell’uomo verso la donna. Nelle scimmie questo è molto chiaro, nell’uomo moderno molto di meno, almeno nelle società occidentali. Questo vuol dire che la pressione selettiva ha avuto un ruolo importante nella selezione dei comportamenti sessuali. Lo ha fatto attraverso degli stimoli scatenanti non più legati alla forma o al colore della pelle (le coppe nei genitali dei guerrieri medioevali o nei colori che utilizzavano gli indiani d’America per dipingersi il viso prima delle battaglie), ma anche a quelli comportamentali (il modo, per esempio, in cui i giapponesi medioevali si sedevano sul tatami). Esistono altri comportamenti che hanno avuto questi ruoli e che non sono solo agonistici, di dominanza e sottomissione, ma anche di tipo affettivo e quindi molto diversi dai primi. Un classico esempio è il modo in cui gli adulti reagiscono di fronte a un neonato. La morfologia infantile (la testa grande rispetto al corpo, gli occhi grandi, le braccia grassocce, la fronte convessa, la pelle soffice e le guance paffute, il vagito, il sorriso eccetera) suscita disposizioni di cura e protezione, non quelle materne ma anche da parte di qualsiasi adulto, anche non imparentato. Similmente osserviamo queste reazioni nei riguardi di un adulto che appare goffo, impacciato, quindi inoffensivo, e che scatena quasi sempre una reazione di solidarietà e di aiuto. Che tutto ciò sia vero lo possiamo verificare persino nei messaggi pubblicitari e nel modo in cui si segnalano dei prodotti per bambini, soprattutto alimentari, che sono sempre sorridenti, belli e in piena salute. Un piccolo mal nutrito, sporco, con il moccolo, mal vestito e brutto susciterebbe una reazione opposta e certo non servirebbe a vendere nessun prodotto per bambini. Chi si occupa di psicologia della pubblicità sa bene queste cose, come sa bene che per vendere un tipo di macchina o degli pneumatici è meglio accostarci una bella donna, seminuda e molto prosperosa. Ora questa pubblicità si vede di meno perché quelle donne belle, prosperose, mezze nude o completamente nude alle quali ci siamo abituati sono state sostituite da altri segnali, per esempio la trasmissione di un senso di benessere economico al possibile acquirente facilitandolo con dei pagamenti rateizzati e senza interessi, nel dargli la sensazione di una forte padronanza nella guida sulla strada che in questi casi, guarda caso, risulta quasi sempre essere deserta, quando sappiamo benissimo che ogni mattina che ci rechiamo al lavoro dalla periferia al centro della nostra città, grazie agli ingorghi, possiamo impiegarci un’eternità.
.png)