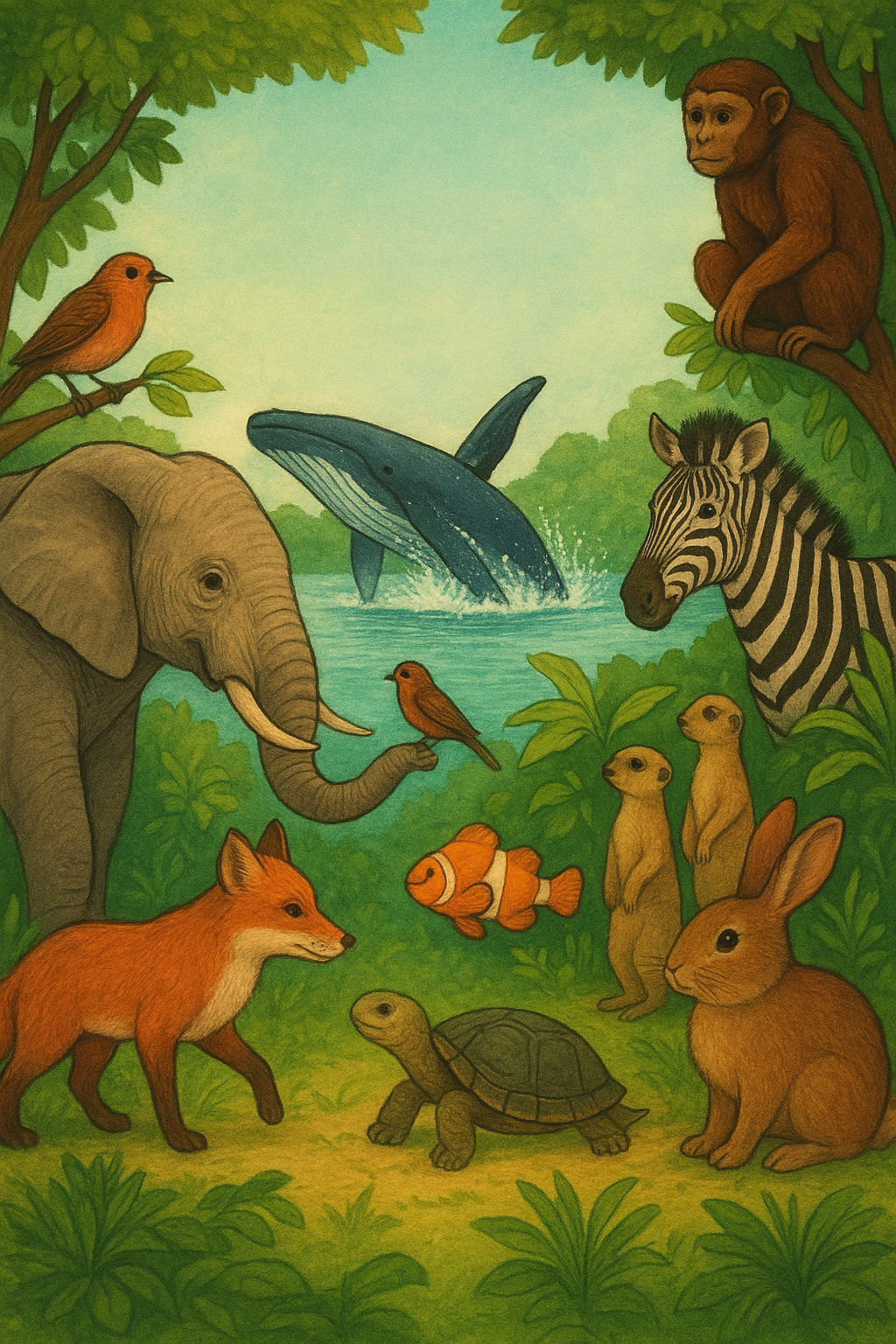La perdita dell’animale domestico: un lutto delegittimato
di Alessia Mazza con il contributo di Silvia Giallorenzo e Giulia Simonetti
Il lutto è un’esperienza dolorosa e fonte di profonde sofferenze. Quando la perdita appena subìta riguarda non più un nostro simile ma un compagno a quattro zampe le ripercussioni in termini psicologici potrebbero risentire di fattori esterni di forte rilievo.
La morte di un animale non è, come si è soliti pensare, diversa da quella che riguarda un essere umano. Quelle che sono state delineate da molti autori come fasi dell’elaborazione del lutto Kübler-Ross (1969), seppur con leggere differenze nelle varie teorizzazioni, si ritrovano allo stesso modo quando il lutto coinvolge il proprio animale domestico (Packman et al., 2011).
Gli animali dal canto loro sono in grado di fornire un amore incondizionato che difficilmente si trova nelle relazioni umane. Le persone possono trovare un rifugio nei loro animali domestici e da loro non si aspettano delusioni. Potrebbe essere ricondotta a questi legami una lettura di “compensazione”, in una società in cui le relazioni umane risultano sempre più instabili e superficiali, le persone potrebbero andare a ricercare negli animali la profondità e la lealtà di cui hanno bisogno e che si trova solo in una società ideale. Pertanto, quando un rapporto del genere viene a mancare, ciò non può che costituire una grave perdita per questi proprietari che potrebbero faticare a trovare altrove lo stesso tipo di amore che gli veniva fornito dal proprio animale.
Inoltre, il proprietario viene considerato un caregiver a tutti gli effetti; tale termine viene utilizzato proprio per indicare un individuo che si prende cura di un altro essere vivente incapace di farlo autonomamente. Gli animali che popolano le nostre case rientrano a pieno in questa categoria poiché necessitano di cure e attenzioni quotidiane. Entrano a far parte della routine dei loro padroni, portando in questo modo anche un senso di impegno e di soddisfazione. Quando essi vengono a mancare si aggiunge al dolore per il compagno perduto anche la perdita di quelle che erano le abitudini che umano e animale avevano costruito insieme, costituendo quindi per gli umani un pezzo della propria persona e della propria vita a cui si deve dire addio.
Inoltre, l’immenso dolore che si prova quando il proprio animale viene a mancare è affiancato dall’impossibilità di condividerlo, di ricercare il “sostegno emotivo” di cui si avrebbe bisogno in momenti così difficili. Il dolore per la morte dell’animale domestico è un dolore non riconosciuto, banalizzato. La società impone che chi sta sperimentando un lutto per un animale debba affrontarlo in tempi decisamente più brevi di quelli previsti per una perdita umana e spesso per cercare di consolare chi sta affrontando tale perdita si suggerisce solitamente di rimpiazzare il proprio animale, di “prenderne un altro”, ma ovviamente questo non rappresenterebbe mai un possibile consiglio per chi sta affrontando il lutto di una persona cara (Cordaro, 2012). Si sa che il supporto sociale è da sempre uno dei migliori ausili per affrontare esperienze dolorose di qualsiasi tipo, ma in questo tipo di perdita tali attenzioni vengono spesso a mancare. È per queste ragioni che il lutto per il proprio animale domestico viene descritto come “disenfranchised grief”, in italiano “lutto delegittimato”, proprio per indicare quanto questo tipo di lutto resta spesso incompreso.
Dover dire addio a un compagno con cui si è soliti condividere gran parte delle proprie giornate, delle proprie abitudini e che mostra in maniera incondizionata il proprio affetto non è certo facile. In più, doverlo fare in assenza del supporto sociale che in tali occasioni si desidererebbe e ci si aspetterebbe dalle persone vicine, complica ulteriormente la situazione.
Lo studio di Lavorgna & Hutton (2019) ha focalizzato la propria attenzione su questo tema operando un confronto tra il lutto per un essere umano e il lutto per un animale, allo scopo di evidenziare differenze e somiglianze e di legittimare l’importanza di quest’ultimo. Il campione utilizzato era comprensivo di 50 adulti di cui 35 avevano affrontato la perdita di una persona e 15 la perdita del proprio animale. I partecipanti dovevano completare un questionario di 20 item comprendente informazioni sociodemografiche, l’Inventory Social Support (ISS; Hogan & Schmidt, 2002), il quale offre una misura del sostegno sociale percepito; un item di vicinanza al defunto e il Prolonged Grief Disorder inventory (PG-13; Prigerson et al., 2009), uno strumento diagnostico che valuta la sintomatologia del lutto per una persona cara e che in questo caso è stato adattato per poter analizzare la sintomatologia in relazione alla perdita dell’animale. I partecipanti hanno anche risposto a una domanda aperta riguardante l’esperienza di lutto che stavano vivendo. Dai risultati è emerso che non era presente una differenza significativa nella severità del lutto per la perdita di un essere umano messa a confronto con il lutto per la perdita di un animale. Non era il tipo di perdita a predire la severità del lutto ma il supporto sociale percepito e la vicinanza al defunto sono risultati predittivi della gravità sperimentata. Dall’analisi delle risposte alla domanda aperta le descrizioni fornite dai soggetti non presentavano grosse differenze riferibili al tipo di perdita (essere umano vs animale). Ciò ha permesso di supportare l’ipotesi degli autori secondo cui le due esperienze di lutto possono essere paragonate e vissute con la stessa importanza. In aggiunta però è emerso un tema presente solo nel gruppo che aveva affrontato la perdita dell’animale, ovvero quello del “disenfranchised grief”. In linea con questo concetto i partecipanti dichiaravano che il loro dolore non veniva spesso capito e quindi si trovavano il più delle volte da soli ad affrontarlo. Da questo studio si evince chiaramente che per certi aspetti i due tipi di lutto possono essere messi a confronto andando a costituire una tra le esperienze più dolorose a cui bisogna far fronte nel corso della vita. Tuttavia, come spiegano gli autori, le barriere sociali ancora impattano sulla percezione che la perdita del proprio animale non possa essere vissuta con altrettanta sofferenza, quanto quella per un proprio simile. Per questo motivo tali persone sono spesso portate a non esternare il loro dolore e a chiudersi in sé stesse, rendendo ancora più difficile il fronteggiamento di tali esperienze.
Lo studio di Eckerd, Barnett, e Jett-Dias (2016) è in linea con questi risultati. Gli autori sono partiti da due domande di ricerca, la prima mirava a documentare se l’esperienza di lutto per coloro che subivano la perdita dell’animale domestico differiva da coloro che subivano la perdita di una persona cara e la seconda mirava a verificare quale tra i seguenti fossero dei predittori per la severità del lutto tra i due gruppi: genere, vicinanza, settimane passate dalla morte, tipo di perdita, cause della perdita e partecipanti online o in laboratorio. Il campione analizzato era composto da 357 partecipanti che avevano subito la perdita di una persona (41%) o di un animale (59%) negli ultimi 2 anni. Sono stati utilizzati il Core Bereavement Items (CBI; Burnett, Middleton, Raphael, & Martinek, 1997) per valutare i sintomi del lutto e il Pet Bereavement Questionnaire (PBQ; Hunt & Padilla, 2006) per valutare il livello di dolore esperito. Il PBQ è stato leggermente modificato in modo da renderlo adatto a misurare il livello di dolore esperito per la morte di una persona. La vicinanza al defunto è stata misurata utilizzando una scala Likert a 10 punti. Dai risultati è emerso, contrariamente all’articolo precedentemente esposto, che la severità del lutto per coloro che avevano subito la perdita di una persona cara era maggiore rispetto a coloro che si erano confrontati con la perdita di un animale. Tuttavia, l’effect size, ovvero l’indice che descrive la forza della relazione tra le variabili esaminate, era piccolo. La differenza, dunque, tra la severità del lutto tra i due gruppi era presente, ma non eccessiva. A loro parere questo risultato può essere spiegato dal fenomeno di delegittimazione del lutto che riguarda esclusivamente la morte dei compagni di vita a quattro zampe. Sarebbe l’imbarazzo che si percepisce per il dolore provato in seguito a queste perdite a farle apparire come meno gravi agli occhi dei padroni stessi. A riprova di ciò, questo studio riporta un ulteriore risultato in grado di fornire una migliore comprensione sul tema. Rispondendo alla seconda domanda di ricerca relativa ai predittori della severità del lutto, la vicinanza è risultata per entrambi i gruppi la variabile di maggior rilievo. Dall’analisi di tali risultati è chiaro come sia l’intensità della relazione a determinare la sofferenza che si prova in risposta a tali eventi. Non era né il tipo di animale, il tempo passato o le cause della morte, come invece ci si poteva razionalmente aspettare, a decretare la severità con cui veniva affrontata la perdita. Piuttosto la vicinanza, il legame emotivo era ciò che portava a vivere l’accaduto come un evento carico di sofferenze.
Dunque, che il proprio compagno perso abbia 4 zampe o 2 gambe non dovrebbe costituire il metro di giudizio con cui valutare la gravità della perdita. Il lutto per il proprio animale domestico può, senza dubbio, essere vissuto allo stesso modo di come verrebbe vissuto il lutto per una persona cara. In più, il non sentirsi capiti, il pensare che quel dolore non abbia ragione di essere così intenso, la sensazione di stare esagerando, tutto ciò porta questi padroni a chiudersi in sé stessi e affrontare il lutto in solitudine.
Ovviamente questo quadro non si verifica sempre. Come già esposto, è il legame tra uomo e animale in primis a determinare come verrà poi percepita la perdita. Non tutti sono legati con forte intensità emotiva al loro animale e non tutti vivono la perdita in modo intenso. Ugualmente, non tutti verranno lasciati soli durante queste esperienze. Tuttavia, sarebbe auspicabile che nessuno si trovasse mai nel caso contrario. Portare alla luce questi risultati e cercarne di nuovi per poter divulgare in modo sempre più forte questo messaggio, potrebbe essere d’aiuto per far sì che ciò non accada. Inoltre si auspica si possano sempre più ampliare le risorse d’aiuto psicologico per i compagni umani di animali domestici.
--
Riferimenti bibliografici:
Burnett, P., Middleton, W., Raphael, B., & Martinek, N. (1997). Measuring core bereavement phenomena. Psychological Medicine, 27, 49–57. doi:10.1017/s003329179 6004151
Cordaro, M. (2012). Pet-loss and Disenfranchised Grief. Implications for Mental Health Counseling Practice. Journal of Mental Health Counseling 34 (4), 283-294
Eckerd, L. M., Barnett, J. E., & Jett-Dias, L., (2016). Grief Following Pet and Human Loss: Closeness Is Key. Death Studies 40(5), 275–282. https://doi.org/10.1080/07481187.2016.1139014
Hogan, N. S., & Schmidt, L. A. (2002). Testing the grief to personal growth model using structural equation modeling. Death Studies, 26(8), 615–634. doi:10.1080/07481180290088338
Hunt, M., & Padilla, Y. (2006). Development of the pet bereavement questionnaire. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People & Animals, 19, 308– 324. doi:10.2752/089279306785415493
Kübler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York: Macmillan
Lavorgna, B. F., & Hutton, V. E. (2019). Grief Severity: A Comparison between Human and Companion Animal Death. Death Studies, 43(8), 521–526. https://doi.org/10.1080/07481187.2018.1491485
Packman W., Field N.P., Carmack B.J., Ronen R. (2011). Continuing Bonds and Psychosocial Adjustment in Pet-loss. Journal of Loss and Trauma 16, 341-357
Prigerson, H. G., Horowitz, M. J., Jacobs, S. C., Parkes, C. M., Aslan, M., Goodkin, K., Maciejewski, P. K. (2009). Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11. PLoS Medicine, 6(8). doi:10.1371/journal.pmed